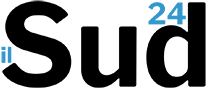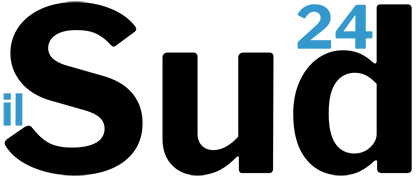Carmela Sermino e la figlia rischiano di restare senza casa
La legalità, quando è priva di umanità, rischia di diventare burocrazia cieca. È questo il nodo che emerge con forza nella vicenda di Carmela Sermino e di sua figlia Ludovica Veropalumbo, oggi minacciate di sfratto da quella stessa casa che il Comune avevano indicato, nove anni fa, come simbolo di riscatto e giustizia.
L’appartamento di via Vittorio Veneto, sottratto al boss Agretti del clan Gionta, fu assegnato nel 2016 con grande enfasi istituzionale: un bene confiscato restituito alla collettività e destinato a una vedova e a una figlia segnate da una tragedia avvenuta in un contesto di violenza camorristica. Un gesto che voleva dimostrare che lo Stato, almeno una volta, sapeva stare dalla parte giusta. Oggi, quello stesso Stato – nella sua declinazione amministrativa – bussa alla porta per riprendersi le chiavi.
La storia di Giuseppe Veropalumbo è emblematica di una delle più grandi contraddizioni del sistema: ucciso da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno, in un contesto riconducibile alla criminalità organizzata, ma mai ufficialmente riconosciuto come vittima di camorra. Una morte «di serie B», che ha privato la famiglia non solo di un marito e di un padre, ma anche di ogni tutela concreta.
La correttezza formale e gli interrogativi
Il Comune si rifugia oggi dietro il regolamento: la concessione dei beni confiscati dura nove anni, il termine è scaduto il 31 agosto e non sono previste proroghe perché mancherebbero i requisiti. Tutto formalmente corretto. Ma è proprio questa correttezza formale a sollevare interrogativi profondi: può la legalità limitarsi a rispettare le scadenze, ignorando completamente il contesto umano e simbolico di quella assegnazione?
L’abitazione, ricordano dagli uffici, doveva avere anche una funzione sociale. Ma viene da chiedersi: il fallimento di un progetto – ammesso che lo sia – può ricadere interamente su chi quel progetto lo ha vissuto come unica ancora di salvezza? Possibile che nessuno, in nove anni, abbia monitorato, accompagnato, sostenuto davvero quell’esperienza? La petizione lanciata da Carmela Sermino non è solo un appello disperato: è l’atto d’accusa di una donna che ha già perso tutto e che oggi vede lo Stato trasformarsi da alleato a esecutore. «Non toglieteci anche la casa», scrive.
Una frase che pesa più di qualsiasi regolamento. Il caso Sermino non è un’eccezione, ma il sintomo di un sistema che celebra i beni confiscati come trofei, salvo poi dimenticare chi li abita quando i riflettori si spengono. In nome della legalità, si rischia di produrre l’ennesima ingiustizia. E questa volta, a pagare il prezzo, sono ancora una madre e una figlia.