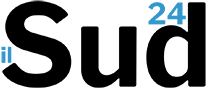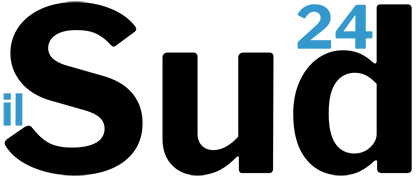Crolli, incuria e narrazione patinata: città usata come palcoscenico
C’è una domanda che Napoli dovrebbe avere il coraggio di porsi, senza ipocrisie e senza sconti: negli ultimi trent’anni questa città è stata davvero governata da chi la sentiva propria? Perché, mentre Napoli viene venduta al mondo come capitale di tutto — dello sport, del turismo, della cultura, degli eventi — la città reale cade a pezzi. Letteralmente.
In meno di due ore crollano palazzi, piovono calcinacci, interi quartieri vengono sfiorati dalla tragedia. Non per fatalità, ma per incuria, manutenzione assente, amministrazione spettacolare e governo inefficace. E intanto chi governa sfila sui red carpet, aspetta l’America’s Cup, incassa titoli e riconoscimenti, alimenta una narrazione patinata che nulla ha a che vedere con la vita quotidiana dei cittadini. Ma forse il problema è più profondo. Forse il fallimento di Napoli nasce da lontano. Trent’anni senza un sindaco «di Napoli». Ripercorriamo le tappe.
Inizi anni ’90: Antonio Bassolino, sindaco simbolo di una stagione politica lunga e ingombrante. Ma Bassolino non è napoletano, viene da Afragola, estrema provincia. Poi Rosa Russo Iervolino: nata a Napoli, sì, ma politicamente e personalmente lontana dalla città, divisa da sempre tra Abruzzo e Roma. Segue Luigi de Magistris: anche lui nato a Napoli, ma formatosi, vissuto e cresciuto politicamente altrove, lontano dalla città, tanto da costruire la propria vita personale e professionale fuori dai confini partenopei. Infine l’ultimo in ordine di tempo: Gaetano Manfredi, il sindaco «nolano», proveniente dal paese accanto a Nola.
Il dato è oggettivo, non ideologico: da oltre trent’anni Napoli non ha un sindaco nato a Napoli, cresciuto a Napoli, politicamente formato a Napoli e profondamente radicato nella sua comunità. Non uno che venga davvero da dentro la città.
E allora la domanda diventa inevitabile: può governare davvero una città chi non la sente visceralmente sua? Può amarla chi la usa come trampolino di lancio, come laboratorio politico, come rendiconto personale per crescere altrove?
Napoli come carriera, non come responsabilità
Negli ultimi trent’anni Napoli è stata spesso strumento, non fine. Una città da amministrare in funzione della propria immagine, della propria carriera, della propria proiezione nazionale o internazionale. Una città ridotta a brand, a racconto mediatico, a palcoscenico permanente.
Ma Napoli non è una passerella. Napoli è fatta di palazzi che hanno bisogno di manutenzione, di strade che cedono, di quartieri dimenticati, di cittadini che vivono con la paura che qualcosa cada dall’alto. Questo non è destino, è fallimento politico.
E la classe dirigente napoletana?
Ancora più grave è il silenzio — o l’incapacità — della classe dirigente politica napoletana. Com’è possibile che in una città di oltre un milione di abitanti non emerga una classe dirigente nata, cresciuta e radicata a Napoli, capace di arrivare a guidarla? Com’è possibile che Napoli debba sempre «importare» chi la governa?
Questo non è solo un problema di nomi. È un sistema che si autoalimenta da trent’anni, che esclude, seleziona dall’alto, premia la fedeltà e non l’appartenenza, la visibilità e non la competenza, il racconto e non la responsabilità.
Serve uno scatto di orgoglio. Napoli non ha bisogno di altri titoli, né di altre autocelebrazioni. Ha bisogno di governo, di cura, di presenza, di amore vero. Quello che non si improvvisa e non si usa per fare carriera. Serve uno scatto di orgoglio collettivo, dei cittadini prima ancora che della politica. Perché una città che non pretende rispetto è destinata a essere usata. E Napoli, oggi più che mai, deve smettere di essere il palcoscenico di qualcuno e tornare a essere la casa di chi la governa.