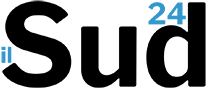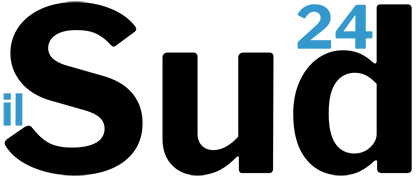Un ragazzo, una Mehari verde, una verità che resiste al tempo
Quaranta. Quarant’anni. Una vita. Una vita intera passata da quella sera del 23 settembre 1985 in via Romaniello, a Napoli. Dieci colpi. Due pistole. Due killer. Ma tanti colpevoli. Esecutori, mandanti, e molti altri responsabili della solitudine e dell’isolamento di un ragazzo che da quattro giorni aveva compiuto ventisei anni. Fa spavento. Specialmente se si pensa a una vita spezzata come quella di Giancarlo. Quarant’anni da quando l’hanno trucidato pensando di eliminarlo. E invece – seppur al costo troppo alto della sua vita – lo hanno reso immortale, presente, inamovibile dalle coscienze. Un eroe? No. Non avrebbe mai voluto esserlo.
Un martire? Certo non lo avrebbe desiderato, e non era quella la sua vocazione. Un alfiere della libertà. Del diritto di cronaca. Della voglia insopprimibile di cercare la verità. Sicuramente. Suo malgrado. Un esempio: certo. E anche essere quello non era il suo scopo. Lui voleva solo essere uno che faceva il proprio mestiere con coscienza, passione, dedizione, scrupolo e senza compromessi. Paradossale dover pensare che questo sia stato il “capo di imputazione” che gli è costato la condanna alla pena capitale.
Decretata da un’Assise dell’Antistato capace di emettere sentenze e dare esecuzione a verdetti in modo veloce e inappellabile perfino nel cuore di quello che avrebbe dovuto essere uno Stato di Diritto capace di tutelare e difendere vite e libertà dei suoi figli. Specie di quelli che ogni giorno si esponevano – e si espongono ancora – per affermare principi e diritti insopprimibili.
Ci sono voluti anni per fare piena luce sui retroscena che portarono all’uccisione di Giancarlo. Inequivocabilmente. Luce piena. Contesto mafioso – non camorristico, come ancora oggi tanti affermano, erroneamente – isolamento, inadeguata comprensione dei rischi reali cui quel ragazzo si stava esponendo.
Le indagini e la verità processuale
A puntare quei riflettori su mandanti, esecutori e contesto preciso, sono stati alcuni uomini che – come Giancarlo – non si sono fermati davanti ad alcun ostacolo: Armando D’Alterio, il Pm che votò anni della propria vita alla risoluzione di quel caso; Giuseppe Auricchio, poi commissario, che fu l’investigatore di punta di quel pool, e l’intero team che sostenne il peso di quel lavoro immane: in primis Raffaele Iezza (il commissariato oplontino all’epoca era retto da Alfonso Maria La Rotonda), Angela Ciriello, Vittorio Pisani, Armando Trojano, Salvatore Cambio.
Questi e solo questi. Questi solo, per una sola, innegabile verità che ha retto al vaglio di tutti i livelli di giudizio, fino a portare alle condanne “in giudicato”. Anche se, ancora oggi, c’è chi – incomprensibilmente – si ostina a voler cercare spiegazioni alternative, fantasiose e suggestive alla morte di Giancarlo.
Come se aver acclarato la responsabilità della mafia del Vesuvio, del clan Nuvoletta di Marano, aver compreso pienamente meccanismo, movente, dinamiche, e aver dato un nome a chi decise e a chi eseguì, non fosse abbastanza. Forse, per qualcuno, questo non soddisfa la voglia di dimostrare altre tesi “di partenza” che fanno più comodo alla propria linea di pensiero. E sarebbe abnorme pensare, anche solo per un momento, che chi rifiuti di accettare la verità processuale – così chiaramente acclarata e così potentemente sostenuta da prove, fatti e riscontri – lo faccia per sgravare la mafia dalle sue colpe.
Il ricordo personale
Oggi, a quarant’anni da quando lo hanno ammazzato, ripenso praticamente ogni giorno al tempo che Giancarlo ed io abbiamo condiviso: lui “abusivo” del Mattino, io giovanissimo cronista allora alle prime armi. Per me era “l’amico più grande” che guidava la Mehari e che incarnava quel che avrei voluto essere. Poi mi avrebbe spiegato lui quanto difficile fosse la strada e quante delusioni, ostacoli avrei dovuto affrontare e quanto fiele stesse ingoiando. Nonostante tutto, però, era la strada che voleva percorrere e che io stesso avevo intrapreso. Oggi la percorro ancora. Anche nel suo segno.
La direzione giusta l’ha indicata e la indica ancora a intere generazioni di colleghi e di ragazzi delle scuole di tutta Italia: cercare. Indagare, approfondire. Analizzare. Comprendere e poi spiegare. Raccontare. La verità. Tutta. O almeno tutta quella che si riesce a portare alla luce. Non per vestire i panni del supereroe. Semplicemente perché va fatto. Con passione e secondo coscienza.
L’eredità di un ragazzo di ventisei anni
Lo ha fatto lui, che era un ragazzo di ventisei anni e quattro giorni. E ha dimostrato che anche a soli ventisei anni e quattro giorni si può sostenere il peso della responsabilità e del dovere, senza farsi sconti. Possiamo farlo tutti. E non solo i giornalisti. Tutti. Ognuno nel proprio campo. Dobbiamo. Dovremmo. Chiediamoci, ogni giorno, se siamo disposti a farlo.